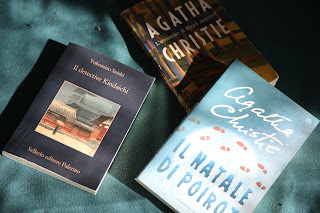Lettera a un bambino mai nato fu un testo che mi colpì molto fin da adolescente, per l'argomento trattato, il modo con cui è stato trattato e la scrittura fluida e poetica di Oriana Fallaci. Anni dopo lessi anche Un uomo, la biografia (molto più cruda dell'altro testo) dell'uomo che la giornalista amò e supportò nelle sue battaglie e che confermò la scrittura dell'autrice fiorentina come particolarmente gradita ai miei occhi; infine, quest'anno, ho recuperato, grazie a un gruppo di lettura, Insciallah, che non ha potuto far altro che consolidare l'amore che ho per questa scrittrice.
L'apertura del romanzo è molto d'impatto, in questo senso, quasi a voler avvisare subito il lettore sul tono dell'opera e costringerlo immediatamente a decidere se avrà abbastanza fegato per proseguire nelle pagine che restano (non sono poche - totale 795 -, quindi è bene chiarirsi subito se vale la pena proseguire). Siamo a Beirut, città che fu teatro di una sanguinosissima guerra civile fra più gruppi religiosi, tra il 1975 e il 1990. In tempi e con modalità diverse, inglesi, francesi, italiani e americani invieranno dei contingenti per cercare di intervenire e garantire la pace (che utopia!, oltre all'arroganza di voler imporre gli ideali occidentali in un altro mondo, effettivamente ricambiata dall'odio e dalle ritorsioni delle popolazioni locali, divise su tutto, tranne che sul fatto di non volere stranieri a impicciarsi degli affari loro). Il contesto in cui si ambienta la storia è dunque vero, ma la storia che inventa Oriana Fallaci è interamente di finzione e ha per protagonisti i militari italiani in missione di pace nella capitale libanese: il romanzo si apre proprio con la strage del 23 ottobre 1983, che colpì le basi militari francese e americana a Beirut e che catapulta il lettore fra brandelli di corpi e bestemmie di mutilati e soccorritori.
Incontriamo il protagonista del romanzo, il matematico e militare Angelo, proprio in questo frangente, intento a scoprire l'orrore della strage e a interrogarsi se esista e quale sia la Formula della Vita, un concetto matematico che possa spiegarla. Angelo è in crisi tra vocazione professionale e legami affettivi, da quando la bellissima libanese Ninette gli fa la corte. La loro storia sarà centrale nella trama e le conseguenze del modo in cui evolve avrà ripercussioni sul destino di molti altri.
Piano piano, oltre ad Angelo scopriamo una lunga serie di altri soldati italiani, di ogni grado e reparto, ognuno a suo modo fondamentale per l'intrecciarsi delle vicende che si scatenano la domenica di ottobre degli attentati kamikaze e che culminano tre mesi dopo. Ogni personaggio ha una sua storia, un'identità, dei legami, qualcosa che lo muove e trovo che l'autrice sia stata magistrale nel crearne così tanti e, soprattutto, nell'annodare ciascuna di queste linee di narrazione (anche se sono talmente tanti che ogni tanto mi dimenticavo di qualcuno, finché non mi imbattevo di nuovo in lui). La riuscita dei personaggi varia e ad alcuni mi sono affezionata, durante la lettura, più che ad altri. La maggior parte di loro ha un arco narrativo carico di tormento: fuggono dai loro passati e cercano, a Beirut o malgrado Beirut, forme di riscatto o di consolazione.
Nei tre mesi in cui si ambientano le vicende, inoltre, conosciamo anche altri personaggi di contorno: i bambini che fanno amicizia con i militari, le suore del convento occupato per farne la base Rubino, Bilal lo spazzino, Passepartou l'adolescente cinico e sadico, e ancora membri di ciascuna delle parti in causa nella guerra. Fallaci ci spiega l'origine di un conflitto, in cui gli interessi di ciascuno sono complessi e, talvolta, mutevoli. Una delle più straordinarie imprese in cui riesce la scrittrice è raccontare ogni diverso punto di vista: soldati di lunga esperienza che amano la guerra, ma che entrano in conflitto con la propria vocazione a causa della guerra e soldati di lunga esperienza che odiano la guerra, eppure vi trovano una sua necessità; uomini che partono con una forte motivazione e la perdono; uomini che lasciano casa pieni di dubbi o di paure e che trovano il loro posto nel mondo; vili che diventano coraggiosi e viceversa; governativi, mussulmani, cristiani, figli di Dio. C'è spazio per la crescita, ma anche per la stasi e per cambiare idea più volte. C'è spazio per descrivere ogni forma di sentimento: l'ardore, la paura, il dubbio, l'amore, l'amicizia, la compassione, la sete di vendetta. Ognuna di queste emozioni e dei pensieri, anche totalmente contraddittori sono riportati con la stessa importanza: è un ecosistema, un piccolo mondo, popolato di personaggi quasi reali, comunque probabili. Oriana Fallaci si annienta quasi del tutto (quasi) e lascia spazio a molte altre voci, in ciascuna delle quali e in nessuna c'è un pezzettino di lei. La biografia della Fallaci ha chiaramente influenzato le sue posizioni sui conflitti e sui suoi protagonisti e quest'opera non sarebbe tale se lei non fosse stata la compagna di Alekos Panagulis. Io, personalmente, rivedo un po' di Oriana nel personaggio di Ninette.
La scrittura ha un ritmo che non è mai serrato, ma conduce inesorabile verso l'appuntamento col destino di ciascun personaggio. Nessuno è dimenticato, perché la struttura è curata al punto da far incastrare tutti i pezzi del puzzle nel giusto posto.
I dialoghi sono frequenti e ogni personaggio parla nella sua lingua o nel suo dialetto, subito seguito da una traduzione integrale o parziale del discorso. Anche se è pur sempre una ridondanza, c'è da ricordare che nel 1990 non tutti avevano ricevuto un'istruzione che permettesse di comprendere il francese o l'inglese, tantomeno l'arabo, il bergamasco, il napoletano o qualunque altra parlata si incontra nel testo. Ulteriori iterazioni sono quelle di alcune espressioni o, addirittura, intere parti di frasi o frasi: queste ripetizioni (nei dialoghi o per enfatizzare la particolare espressione usata) possono essere considerate fastidiose, ma, per conto mio, sono necessarie le prime e apprezzabili le seconde.
Si leggono crudeltà spaventose in questo libro (Un uomo non era da meno ed è citato a un certo punto), ma è anche un romanzo sofisticato per molti versi, tra cui l'aspetto metaletterario. Oriana s'intravede in trasparenza sia come personaggio, sia come autrice, che si fonde a sua volta con un altro personaggio, che scrive lettere a una moglie che non ha e anche una sua piccola versione dell'Iliade, con protagonisti gli uomini che lo circondano.
In conclusione, questo libro è molte cose: è ricco dal punto di vista degli avvenimenti, degli intrecci, delle emozioni che suscita; è intricato dal punto di vista dalla struttura. Consente un approfondimento su di un conflitto di cui non sapevo nulla, ma soprattutto sulla natura umana, che una donna esperta e stanca degli uomini come Oriana Fallaci aveva ben conosciuto. L'autrice si lancia contro e a favore dell'umanità che descrive, traendo spunto dalla realtà, dall'ipocrisia e dalle generosità che ha incontrato, anche perché, come sostiene l'autrice, entrambi i punti di vista, entrambe le possibilità sono plausibili e coesistono.
Giudizio: ⭐⭐⭐⭐1/2